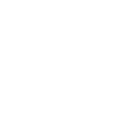Topografia
Approfondimenti
Lessico

La storia


Tecnica
Celerimensura
Agrimensura
Topografia sf. [sec. XVI; dal greco topographía, da tópos, luogo, e -graphía, da gráphein, scrivere]. Scienza che studia i metodi per la determinazione planimetrica e altimetrica di punti con le relative tecniche di misura e gli strumenti per le osservazioni ai fini del rilevamento terrestre di una limitata estensione di territorio di circa 15 km di raggio detto campo topografico.

La topografia è una delle scienze più antiche. Gli Egizi misuravano i terreni lungo il Nilo per ritracciarne i confini dopo i periodici straripamenti del fiume. I Greci e soprattutto i Romani impiegavano metodi topografici già molto precisi; squadre di topografi (i gromatici), al seguito delle legioni romane tracciavano confini e dividevano le terre conquistate in appezzamenti regolari, poi descritti e rappresentati su tavole di rame. Presso gli Arabi la topografia servì alla costruzione di carte geografiche e alla misurazione di superfici agrarie e di terreni a uso catastale. Scienza in senso moderno divenne però a partire dai sec. XVI-XVII: G. Praetorius mise a punto la sua tavoletta per rilevamenti rapidi di precisione e V. Snellius introdusse il metodo delle triangolazioni e risolse problemi e metodi d'intersezione. I Cassini svilupparono nel sec. XVIII la cartografia topografica, dapprima in Francia e poi negli altri Paesi europei, dando impulso al perfezionamento e alla costruzione degli strumenti, ramo nel quale i maggiori progressi si realizzarono tra la fine del sec. XIX e i primi decenni del XX con la costruzione del cleps (I. Porro) e in seguito con il teodolite e il tacheometro ad opera di C. Zeiss (1816-1888) e di altri. Con l'introduzione della fotogrammetria terrestre (fine sec. XIX) e aerea (inizio sec. XX), la topografia assume un ruolo fondamentale nella determinazione di punti da utilizzare nell'inquadramento geometrico ai fini della restituzione analogica o analitica per l'elaborazione di cartografia rilevata. Comunque la topografia interviene sempre nella risoluzione di problemi riguardanti operazioni catastali, rilievi per la progettazione di ferrovie, strade, dighe, acquedotti per l'irrigazione, lavori minerari ecc.


Nel settore degli strumenti topografici oltre ai tradizionali tacheometri e teodoliti (che differiscono solo per la precisione nelle letture angolari) si sono aggiunti i geodimetri per la misura delle distanze, che, quando sono montati sopra un tacheometro/teodolite, danno luogo alle cosidette “stazioni totali”. I metodi per la determinazione di punti in topografia sono per molti aspetti affini a quelli impiegati nel settore geodetico: la differenza sostanziale, oltre quella di impiegare strumenti di minore precisione e di diminuire il numero delle osservazioni, è che in topografia si opera nel campo topografico e quindi si utilizzano solo le relazioni della trigonometria piana e non quelle della trigonometria sferica ed ellissoidica. Le determinazioni planimetriche topografiche utilizzano i procedimenti della triangolazione e della poligonazione, misurando angoli e distanze. Quelli della triangolazione prevedono metodi di autodeterminazione e di intersezione in avanti, laterale e inversa (problema di Pothenot, Hausen, Marek, Collins ecc.); quelli della poligonazione utilizzano misure anch'esse di angoli e distanze lungo poligonali aperte o chiuse. Le determinazioni altimetriche consistono nella misura dei dislivelli tra punti impiegando metodi di livellazione geometrica o trigonometrica, partendo da almeno un punto di quota nota. Fanno parte della topografia anche i metodi di rilevamento impiegati nell'agrimensura e nella celerimensura.
Celerimensura sf. [dal latino celer celeris, celere+mensūra, misura]. Metodo di rilevamento planimetrico e altimetrico del terreno mediante l'impiego del tacheometro o del teodolite e della stadia, senza misura diretta delle distanze; è detto anche tacheometria o rilevamento numerico. Il principio fondamentale della celerimensura consiste nel riferire i punti da rilevare a un sistema di tre assi cartesiani ortogonali X, Y, Z, con l'origine in un punto A di coordinate note detto “punto di emanazione”, e nel calcolare per ognuno di essi le coordinate riferite a tali assi, di cui le prime due forniscono la posizione planimetrica e la terza rappresenta la quota. Caratteristica principale della celerimensura è di ridurre al minimo le operazioni sul terreno; a tale vantaggio fa però riscontro un lavoro di calcolo sui dati raccolti, ovviato in parte dall'uso di tavole numeriche dette Tavole Napoletane e di strumenti autoriduttori. La celerimensura fu introdotta da I. Porro nel 1823; in realtà più che di un nuovo metodo di rilevamento si tratta di una razionale organizzazione di operazioni topografiche già conosciute. Per l'esecuzione del rilievo celerimetrico si procede nel modo seguente: si staziona con un tacheometro, teodolite dotato di cannocchiale centralmente anallattico e munito di reticolo distanziometrico, in un punto A di posizione nota; si orienta il cerchio azimutale su un altro punto noto per cui gli angoli letti allo strumento sono degli azimutsi pone la stadia verticale nel punto P da determinare e una volta collimata con il tacheometro, previamente rettificato, si rilevano su di essa gli elementi che permettono di calcolare le coordinate cartesiane di P, tenendo presente che il sistema di assi ha origine nel punto A e che l'asse Y delle ordinate è disposto nella direzione del meridiano. Tali elementi detti “numeri generatori” sono la lettura al cerchio azimutale per l'angolo α, la lettura al cerchio zenitale per l'angolo z e i valori dei tre fili distanziometrici del cannocchiale sulla stadia. Si misura inoltre l'altezza strumentale ΔI dello strumento sul punto di stazione A e l'altezza della stadia ΔM dal suolo. Da questi elementi, annotati in un apposito registro, si ottengono con semplici passaggi trigonometrici le formule per il calcolo delle coordinate e della distanza del punto P. La distanza orizzontale D risulta essere D=KS sen²z, dove K è la costante distanziometrica del cannocchiale dello strumento e S è l'intervallo letto sulla stadia; le coordinate e la quota di P vengono calcolate con le seguenti formule:
Affinché la celerimensura sia veramente vantaggiosa bisogna ridurre al minimo il numero delle stazioni; queste devono essere poste a una distanza reciproca compresa tra 50 e 400 m, a seconda della precisione richiesta. Se si ricorre a più stazioni queste devono essere collegate in modo che i punti rilevati vengano riferiti alla stessa terna assiale; sono necessari pertanto per ogni stazione la determinazione planimetrica e altimetrica e l'orientamento rispetto alla precedente.
Agrimensura sf. [sec. XVIII; dal latino agrimensūra]. Parte della topografia che si occupa della misura, delle divisioni e della rappresentazione della superficie agraria. I problemi della misura del terreno erano già noti nell'antichità: si conoscono papiri egizi del 1700 a. C. che danno norme pratiche per la ripartizione dei terreni; è inoltre noto che le legioni romane avevano al seguito degli esperti agrimensori, i gromatici, che avevano il compito di misurare e di suddividere le terre conquistate. Queste operazioni costituirono i primi rilevamenti topografici eseguiti con metodi scientifici e per tale motivo il termine agrimensura fu usato all'inizio per indicare l'intera topografia e solo molto più tardi fu inteso in senso restrittivo come rappresentazione e misura di aree. È da notare che per superficie agraria non si intende la superficie effettiva del terreno, ma la sua proiezione planimetrica, ossia la proiezione su un piano orizzontale. La superficie effettiva, infatti, è soggetta a continue variazioni dovute agli agenti esogeni che ne modificano la morfologia (per esempio, frane, alluvioni, ecc.); inoltre l'estensione di una coltura è proporzionale allo sviluppo orizzontale del terreno. I metodi impiegati in agrimensura si dividono in tre grandi categorie. I metodi numerici, che sono i più precisi, consentono di ottenere l'area mediante il calcolo sfruttando i dati del rilevamento planimetrico (planimetria). Con i metodi grafici l'area viene ricavata misurandola su una rappresentazione planimetrica fatta in una determinata scala. I metodi meccanici consistono in misure con strumenti meccanici (planimetri) su una rappresentazione cartografica. Altri scopi dell'agrimensura sono la ripartizione di un terreno in appezzamenti e la rettifica di confini tra due proprietà. Questi problemi sono essenzialmente geometrici, ma si seguono alcune norme pratiche intese a mantenere la linea di divisione fra proprietà il più possibile rettilinea e a evitare la formazione di angoli acuti che disturberebbero le coltivazioni.